Ti ricordi il corso di scrittura emozionale, tenuto dalla scrittrice Monica Marelli in collaborazione con la libreria Virginia e Co di Raffaella Musicò?
E’ un corso in cui si è imparato a scrivere in base alle proprie emozioni, ascoltandole, accogliendole ed elaborandole; Monza Reale ha voluto collaborare dando la possibilità alle allieve di pubblicare i loro racconti sul blog in modo da scoprire tramite le loro parole angoli della nostra città.
Oggi abbiamo il piacere di ospitare quello di Raffaella Musicò, la proprietaria della magica libreria Virginia e Co di via Bergamo a Monza.
Ci racconta qualcosa di lei:
“Mi chiamo Raffaella Musicò, sono la libraia di Virginia e Co. a Monza: ho realizzato un sogno e ora per me la realtà e la magia sono inscindibili. Ogni giorno mi alzo e penso di fare il mestiere più bello del mondo.
Scrivo e leggo da quando mi è stato fisicamente possibile imparare, ma ho fatto un sacco di mestieri nella vita, anche molto diversi fra loro.
Quelli che mi sono piaciuti di più sono: birraia, commessa di libreria (prima di avere Virginia e Co.), revisore di testi a contenuto culturale e toelettatrice di cani.
Ora che Virginia e Co. esiste, penso che starò in mezzo ai libri per il resto della mia vita – a leggerli e magari anche a scriverli. Spero quindi di vivere molto, molto a lungo”
Ecco qui il suo bellissimo racconto:
IL CANTO DELLA SIRENA
“Passava spesso davanti al portone dell’ufficio in cui lavoravo, ci passava dalle tre alle quattro volte al giorno. Io lo vedevo perché scendevo a fumare. Un paio di volte aveva il cane, le altre no. Avanzava leggermente sporto in avanti, come se stesse fendendo le acque. Guardava dritto davanti a sé, ma guardava lontano, come dovesse raggiungere un attracco a lungo desiderato. Aveva addosso vestiti morbidi e sempre molto sportivi.
Eppure era elegante, mi stordiva vederlo camminare con quella leggiadria – pur solcando acque molto profonde – e al tempo stesso con la curiosità di un vero esploratore.
Erano i suoi muscoli, compatti e pulsanti, a dirlo, era la sua faccia con qualche ruga e una carnagione color miele, scurita, ne ero certa, rispetto all’originale infantile. Forse anche la barba curata e non troppo lunga e le mani che scolpivano l’aria dando vigore alla camminata.
Passava sempre sul marciapiede opposto a quello in cui stavo io, con la mia sigaretta in bocca, i vestiti scomodi, le scarpe da pochi passi, i capelli tinti.
Quando pioveva aveva addosso un k-way con il cappuccio sugli occhi; io stavo semplicemente appiccicata al portone, cercando di ripararmi sotto il piccolo balcone del primo piano.
Poteva essere un artista. Io avrei detto che fosse un fotografo. Magari invece scolpiva animaletti di legno nelle notti buie, con il cane ai piedi a tenergli compagnia.
Io guardavo di continuo l’orologio, per non esagerare con la pausa e beccarmi l’occhiata di rimprovero. Tenevo la contabilità. Tutto quell’ordine e quella precisione. La coerenza, le somme, le fotocopie, l’archivio. Trovare un posto per ogni cosa. Incasellare, far quadrare, registrare, ricordare. Saper dare delle risposte senza dubbi.
Lui, invece, era libero. Questa parola mi piaceva così tanto che avrei potuto prendermi un animale – uno qualsiasi tranne uccelli e pesci – solo per potergli affibbiare questo nome.
Forse il suo cane si chiamava così. O forse lui non aveva bisogno di affermare un bel niente, era libero e basta.
Mentre io pensavo a quale nuovo takeaway avrebbe salvato la mia serata, lui cavalcava onde scrutando l’orizzonte.
A furia di vederlo passare e ripassare, mi fece venire voglia di prenotare un viaggio, di quelli all’avventura, in cui si parte con un gruppo di sconosciuti e ogni giorno ci si arrangia con il mangiare e il dormire e si cerca di non ammazzarsi l’un l’altro. Me ne stavo lì, con la mia sigaretta in bocca, a pensare alle emozioni che avrei provato. Altro che libro su una spiaggia affollata o sulla sdraio di un rifugio di montagna. Altro che piscina in città o pomeriggi sul divano con il ventilatore acceso.
Sarei andata alla scoperta.
Nuovi mondi mi avrebbero dato il benvenuto, il cuore si sarebbe aperto. E chissà, al ritorno magari avrei potuto anche io camminare fendendo le acque, con lo sguardo colmo di esperienza. E a quel punto nulla avrebbe potuto più separarci: io e lui verso un destino avventuroso e magico, uniti nella buona ma soprattutto nella cattiva sorte, nelle avverse condizioni della vita, di fronte a ostacoli e impedimenti, noi due invincibili. Anche con il suo cane, però: certo non lo si poteva lasciare indietro. Anzi, ci avrebbe fatto comodo in più di un’occasione, una difesa dai pericoli, uno scudo contro le minacce violente, un corpo caldo a cui stringersi. Mi venne anche in mente, un giorno di caldo particolarmente torrido, che avremmo potuto anche sfamarci con la sua carne, se ci fossimo persi con la prospettiva di morte certa. Questo sì che ci avrebbe unito ancora di più, carne della mia carne, sangue del mio sangue. Avremmo onorato il sacrificio della povera bestia annodando i nostri spiriti e i nostri corpi, tutti e tre, per sempre.
Altro che solcare le acque, avremmo imparato a volare. Ognuno ammirando le evoluzioni dell’altro, ascoltando il suono della sua libertà, e poi tornando insieme, a tenerci per mano.
Io con la mia sigaretta e le scarpe che mi facevano male, lui con le sue camicie blu con il colletto alla coreana, la barba e le cosce muscolose e forti.
Prenotai un viaggio in Yemen. Per agosto, perché era l’unico periodo in cui mi era concesso andare in ferie. Eravamo a giugno inoltrato, mancava poco. Lavoravo di buona lena, c’era molto da fare. Ma i miei occhi adesso riuscivano a guardare oltre, a vedere l’orizzonte in cerca di una via da percorrere. Un fremito mi percorreva battendo i tasti di una calcolatrice, scrivendo quelle due cifre uguali in fondo alle colonne, riponendo il faldone delle fatture.
Smisi di tingermi i capelli, li lasciai crescere per poterli legare in una coda che mi sfiorava la base del collo. Un giorno mi misi persino i sandali – non portavo scarpe aperte in città, mi davano un’idea di osceno quei piedi nudi, eppure, lo feci (e non solo quel giorno). Sentivo l’aria sfiorarmi la pelle, mi piaceva. Accorciai le unghie delle mani, cominciai a portare anelli di turchese piuttosto vistosi. Mi liberai dei pantaloni, comprai dei lunghi e ampi vestiti di canapa grezza.
Lui continuava a passare, su e giù, tutti i giorni, tre o quattro volte al giorno. Sempre con quello sguardo da capitano dei cieli.
La via Bergamo – il cuore della nuova ed esaltante movida monzese – risplendeva di candele sui tavolini all’aperto, di risate, di strass sulle magliette, di orecchini enormi e sottili come spaghetti. Il vociare, i tacchi, le borse nuove e i profumi al sandalo invadevano la strada già alle sette di sera. Si sentivano tintinnare i bicchieri in brindisi vivaci, qualcuno, dalle finestre che si affacciavano sulla strada, gridava di fare silenzio, ma smetteva quasi subito. Un’allegria inarrestabile cavalcava il caldo, il blu del cielo, la luce della luna.
Arrivò il giorno della partenza. Non ci potevo credere, io che andavo in un luogo di cui sapevo quasi solo il nome. Le uniche informazioni che mi ero presa la pena di reperire riguardavano l’abbigliamento: l’ultima cosa al mondo che avrei desiderato era essere lapidata per una gonna troppo corta.
Devo dire che l’idea di andare da sola mi spaventava non poco, naturalmente avrei preferito che lui venisse con me, ma c’era l’insormontabile – almeno per il momento – ostacolo costituito dal fatto che neanche sapeva come mi chiamavo. Sarebbe bastato attraversare la strada e chiedergli qualcosa sul suo cane – che è un argomento a cui nessun proprietario di cane si sottrae, MAI.
Ma l’aereo mi aspettava di lì a poche ore, ormai non era più cosa fattibile.
Gli avrei portato un souvenir – al suo cane, beninteso, non a lui per non apparire sfacciata – e lui avrebbe visto brillare nei miei occhi il caleidoscopio di emozioni che mi avevano accompagnata per tutto il viaggio. Avrebbe sorriso, mi avrebbe ringraziato, mi avrebbe, magari, offerto un caffè.
E se avessi avuto ragione sul fatto che era un fotografo, ecco che mi avrebbe chiesto di vedere i miei scatti di luoghi così remoti e affascinanti. Ci saremmo dati appuntamento per cena, magari a casa sua, e io mi sarei messa finalmente quel dannato vestito rosso geranio comprato due anni prima e rimasto a mugolare di dolore nell’armadio per tutto il tempo, completamente abbandonato. Sul divano, con le teste vicine a guardare le foto nel telefono, a raccontare, a bere del vino fresco, accarezzando il cane che ovviamente sarebbe stato tranquillo ai nostri piedi.
Praticamente facevo quel viaggio per lui.
Mi feci coraggio e salii quella scaletta.
Tornai illesa e felice quattro settimane dopo. Ero un’altra persona. Mi sentivo piena e vigorosa, e avevo l’impressione di scivolare sull’asfalto come avessi delle sfere di acciaio sotto i piedi. Quel posto mi aveva iscritta tra le donne che sanno com’è la vita. Quella vera, intendo. Quella in cui sono gli scambi con le persone e con la natura a influenzare il tuo modo di vedere, i tuoi sentimenti, le tue audacie e le tue paure; e sono scambi senza filtri, di nessun genere. Ci muoviamo tutti nell’aria e sulla terra e condividiamo un destino che ha molti più punti in comune di quanto crediamo.
La gioia che avevo provato in quelle settimane in cui me ne ero stata con gli altri, a ridere e a riflettere, a camminare e a guardare il cielo, mi aveva acceso lo sguardo.
Non ero poi così tanto certa di volermi buttare fra le braccia dello sconosciuto artista con cane.
Perché poi, che bisogno c’era? Durante quel viaggio il mio cuore si era aperto e aveva incluso anche me nell’operazione complessa ma entusiasmante di amare l’umanità.
Quindi tornai in ufficio e ricominciai a scendere giù, e a stare davanti al portone a fumare la mia consueta sigaretta, con lo sguardo perso nelle meraviglie del mondo.
Finché me ne accorsi: c’era un cartello, meglio, una targa di metallo con una scritta in blu che diceva: “Vietato fumare nell’area davanti al portone”. Ero sbigottita. Allibita. Ma quando l’avevano messa? Era stato per colpa mia e delle mie cinque sigarette al giorno? Ma come potevano limitare così la libertà personale? Non eravamo mica in uno di quei paesi musulmani che ormai conoscevo bene! Una sorta d’ansia mi si aggrappò al cuore e mi tolse, seppure per un attimo, il respiro.
Attratta dall’incedere dell’artista con cane sul marciapiede opposto, di fronte a me vidi l’incavo di un enorme portone di legno, aperto e accogliente e, proprio sopra, un balcone, molto simile a quello sotto il quale mi riparavo io nelle giornate di pioggia. Strano come non ci avessi mai fatto caso. Forse avevo speso tutto il mio tempo ad aspettare di veder comparire il fiero capitano all’orizzonte e non mi ero accorta di nient’altro. Mi venne in mente di andare a verificare se lo stesso divieto vigesse anche di là. Al pensiero seguì l’azione, devo andare-muovo i piedi-lo sguardo all’obiettivo.
Perciò non vidi la macchina, il conducente non vide me e, accelerando come tutti su quel tratto in cui non c’erano dissuasori, mi uccise sul colpo”
Per richiedere informazioni sui prossimi corsi di scrittura emozionale scrivi una mail a: monica.marelli@gmail.com
A presto con un altro bellissimo racconto!
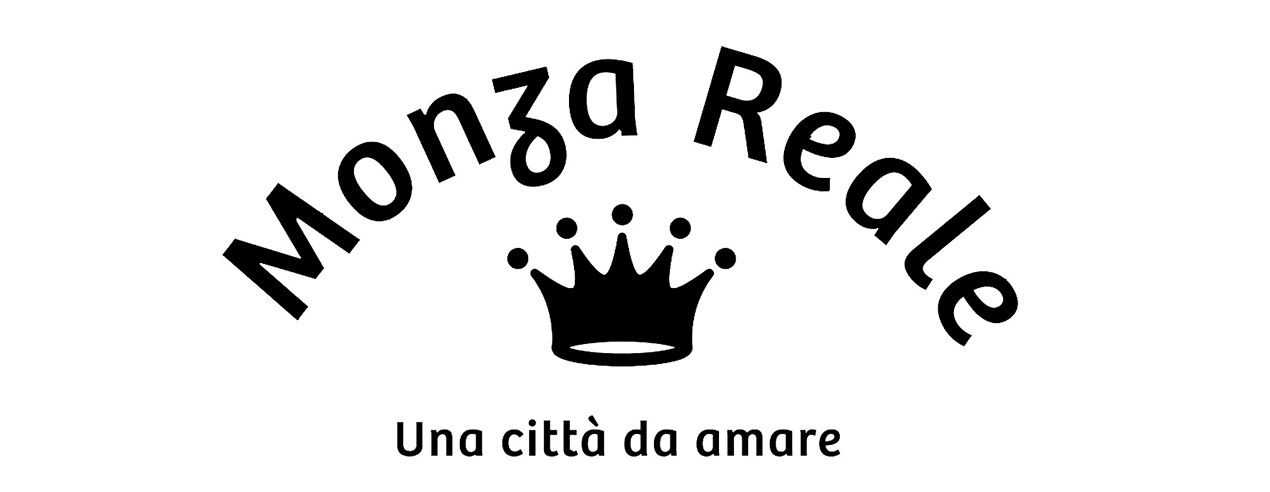





 Vuoi vedere una mostra che ti stup
Vuoi vedere una mostra che ti stup
 Riesco a scrivere solo or
Riesco a scrivere solo or


COMMENTI DISABILITATI SU QUESTO POST